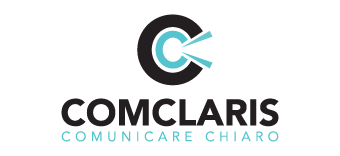Prosecco di collina e di pianura: una bollicina, due mondi
Incontro con Gianluca Bisol della storica cantina di Valdobbiadene, un uomo che ha contribuito allo straordinario successo di questo vino: “È sbagliato parlare genericamente di Prosecco”
Qualcuno le ha definite “bollicine di serie B”, perché il Prosecco non fa parte dell’aristocrazia degli spumanti – identificata nella produzione secondo il metodo classico – alla quale appartengono lo Champagne e tanti suoi confratelli.
A volte però, anche chi predilige il metodo Charmat e apparentemente gioca in serie B, sa prendersi le sue belle soddisfazioni. Così il Prosecco negli Stati Uniti, dopo un’ascesa inarrestabile, lo scorso anno ha superato per quota di mercato lo Champagne: 28% per il vino prodotto nel Triveneto, 26% per quello transalpino.
Gioie e dolori, verrebbe da dire, pensando alla questione dazi tuttora pendente sull’export verso l’America, che non scalfisce però la soddisfazione di chi il Prosecco lo produce non da anni, ma da secoli, come Gianluca Bisol presidente onorario e ambasciatore nel mondo dell’omonima azienda di Valdobbiadene – entrata a far parte del Gruppo Lunelli, polo d’eccellenza del bere italiano – un uomo che, grazie alla sua passione e alla sua filosofia imprenditoriale, è riuscito a portare con successo il Prosecco nel mondo.
“Diciamo che per una famiglia come la mia, che dal 1542 coltiva la vite e produce del vino a Valdobbiadene, il risultato americano è sicuramente una grande soddisfazione. Però vorrei fare delle precisazioni, prima di tutto dicendo che il Prosecco si divide in tre categorie: DOC, Superiore DOCG e Cartizze. Non possiamo dunque parlare di Prosecco genericamente. In America, così come anche in Inghilterra, questo vino è diventato uno spumante che accompagna tutte le ore del consumatore, dall’aperitivo al tutto pasto, al dopocena, ai party e alle feste. Però mi piace abbinare sempre la parola “superiore” alla parola Prosecco, così siamo in chiaro che berremo bene. Se chiediamo un Prosecco, chiediamo questa tipologia, un vino che si sposa con ogni momento della nostra giornata e a questo deve il suo successo. Il Prosecco ha una gradazione più bassa rispetto ad altri spumanti del mondo, piace al primo approccio ed è di una bevibilità straordinaria”.
Parecchi però, anche in Italia, considerano il Prosecco non all’altezza degli spumanti prodotti col metodo classico. Aleggia sempre un po’ l’impressione che bere del Prosecco equivalga a bere un vino di secondo livello…
“Il prezzo è un fattore che condiziona molto lo stile dei consumi. Nel mondo delle bollicine ai prezzi più alti c’è lo Champagne, poi ci sono i metodi classici italiani e solo in terza battuta arriva il Prosecco. Così uno pensa che sia un prodotto di secondo o terzo livello. In realtà, dovremmo dividere per tipologia in modo chiaro e schematico il mondo delle bollicine. Quando si dice Champagne si parla di metodo classico o metodo champenoise, definizione, questa, della quale i francesi hanno rivendicato l’uso esclusivo. Il Prosecco si situa in un’altra categoria: è l’unico spumante al mondo che ha avuto un successo planetario senza alcuna volontà di assomigliare allo Champagne. Anzi: direi che ha fatto proprio di tutto per non assomigliare allo Champagne e dovrebbe essere un orgoglio italiano perché, grazie a una tradizione secolare, siamo riusciti a proporre un’alternativa nel mondo delle bollicine senza imitare lo Champagne”.

Come produttori non ci avete messo anche un po’ del vostro nel creare confusione tra i consumatori, che non riescono a identificare con chiarezza le varie tipologie di Prosecco? In questo senso, l’estensione della DOC non ha danneggiato un po’ l’immagine del vostro vino?
“Più aumenta la quantità e più si ha difficoltà a far percepire al consumatore le differenze che ci sono all’interno di un’area di produzione. Però non dobbiamo dimenticare che oggi il Prosecco, rispetto a un’altra area molto conosciuta a livello mondiale come quella dei Bordeaux, è la metà in termini di ettari di vigneti. Stiamo parlando di una zona molto importante dal punto di vista quantitativo, la più grande per quanto riguarda le bollicine, però si tratta di un territorio che, tutto sommato, ha una dimensione ancora contenuta. Riguardo l’estensione della DOC, in realtà non si è avverata: c’è stato invece un upgrade da IGT a DOC per l’area pianeggiante che occupa nove province del Veneto e del Friuli. Anche a Bordeaux esistono proposte diverse: ci sono bottiglie vendute nei supermercati in Germania a 3,50 euro e vini da 1.500 euro a bottiglia nelle zone più vocate, quelle dei grandi Cru. Lo sa che su 8 bottiglie prodotte, solo una proviene dalla zona storica, quella che dà origine al Prosecco Superiore, cioè il territorio di Valdobbiadene, Conegliano e Asolo? Le altre 7 sono prodotte nella pianura del Veneto e del Friuli, mentre una sola bottiglia su 800 proviene dalla collina di Cartizze a Valdobbiadene, che può essere considerata il Grand Cru del Prosecco. Io penso che si debba riuscire a comunicare meglio l’immagine del nostro vino, magari unendo i tre consorzi attuali – che parlano tre lingue diverse – in un unico consorzio che sappia comunicare al consumatore quanto è semplice riconoscere un buon Prosecco da un Prosecco diciamo… più quotidiano”.

Eppure si sente dire che il grande successo del Prosecco stia anche, se non soprattutto, nella capacità di fare marketing di voi produttori…
“Non credo che il successo dipenda dalla nostra capacità di fare marketing. Penso invece che la natura abbia fatto a noi viticoltori uno dei più bei regali in assoluto: la Glera, il vitigno da cui nasce il Prosecco, facile da produrre grazie alla qualità dell’uva, ai suoi profumi e ai suoi aromi fantastici e unici. Questa bollicina è diversa da ogni altra bollicina al mondo, è inimitabile. Tornando al marketing, penso che i produttori di Prosecco Doc si siano incredibilmente arricchiti e per spirito di inferiorità spesso si sentono rivali del Prosecco Superiore. Invece dovrebbero celebrare ogni giorno le storiche colline di Valdobbiadene investendo lì le immense ricchezze create nella pianura grazie alla secolare tradizione viticola originaria delle ripide colline del Prosecco Superiore. Perché dove adesso ci sono le vigne del Prosecco DOC, prima si coltivavano Merlot, Cabernet, cereali, mais e girasole. Il successo del Prosecco non dipende dal marketing, ma dalla sua bevibilità straordinaria e da un rapporto qualità-prezzo che non ha nessun’altra bollicina al mondo”.
Anche se, in questo senso, bisogna dire che negli anni il prezzo è aumentato in maniera esponenziale.
“L’osservazione è interessante, ma è vera solo in parte. Se, per evitare che la parola Prosecco fosse utilizzata in ogni angolo del mondo, nel 2009 non fossimo stati costretti a concedere la denominazione Prosecco alla pianura del Veneto e del Friuli, la progressione del prezzo sarebbe stata ben superiore”.

Che fine ha fatto il Prosecco scaraffato che si beveva negli anni Ottanta?
“C’è ancora! Ed è un vino che io adoro. Si chiama Prosecco “Sur Lies” (sui lieviti, ndr) e devi proprio scaraffarlo per poter eliminare i lieviti che devono rimanere sul fondo della bottiglia. Mi dicono tra l’altro che questa tipologia di Prosecco a Parigi si beve molto volentieri e ha un grande estimatore nel grande designer Philippe Starck, che conosco perché viene spesso a Burano, dove noi abbiamo il Wine Resort Venissa”.
E questo “Sur Lies” come si produce?
“Nasce seguendo i ritmi della natura, grazie all’uva che veniva raccolta per ultima tra la fine di ottobre e i primi di novembre. Dunque non faceva in tempo a iniziare la fermentazione, o se la iniziava non la terminava nelle piccole cantine di un secolo fa, che non disponevano della temperatura controllata. In primavera, contenendo ancora molti zuccheri naturali dell’uva, coi primi caldi ripartiva la fermentazione e il vino, diventato spumante, veniva messo in bottiglia, dove depositava i lieviti sul fondo. Per berlo è dunque consigliabile scaraffarlo, così si separano i lieviti e il vino diventa limpido, anche se a me piace sbatterlo e berlo così com’è”.
Il Prosecco rosé era invece un vino davvero necessario?
“Il rosato è stato una naturale evoluzione del Prosecco, anche se i maligni dicono che sia un’invenzione per vendere di più. È ovvio che abbia portato a una vendita maggiore, però il rosé nasce dalla curiosità dell’uomo di fare delle cose diverse con gli stessi ingredienti. Forse in pochi lo sanno, ma da sempre il disciplinare del Prosecco prevede che si possa utilizzare del Pinot Nero fino a un massimo del 15%. Solo che, sino al 2019, era proibito lasciarlo sulle bucce per prendere colore. L’unica variazione, rispetto al disciplinare, è stata quella di provare, solo nella denominazione DOC e non in quella di Superiore, a far macerare il Pinot sulle bucce prendendo un po’ di colore per unirlo con la Glera e originare il rosé. Non mi sembra scandaloso. Da sempre anche lo Champagne ha una versione rosata, ma sicuramente qualche purista l’avrebbe voluto solo bianco”.

Cos’ha di magico la collina di Cartizze a Valdobbiadene?
“È l’esempio di come ogni vitigno abbia un luogo che gli permetta di emergere, di dare il meglio. La collina di Cartizze ha un’origine geologica diversa dalle altre colline del territorio circostante e uno sviluppo verticale di circa un chilometro, sul quale la viticoltura è tutta manuale. È esposta a sud, ventilata da Venezia, dal mare dell’Adriatico, tutti i giorni dalla mattina presto fino alla sera; mentre di notte, invece, arriva giù l’aria fredda dei canaloni delle Dolomiti. Quindi ha un’escursione termica pazzesca, ideale. Ha un suolo di origine sabbioso con arenarie marine e rocce con fossili marini sotto circa un metro di terra, e solo lì puoi lasciare l’uva da una settimana a dieci giorni in più senza perdere acidità. È l’unico luogo del nostro territorio dove l’acidità non è un’emergenza per la vendemmia. Quindi, lasciando maturare di più l’uva, ottieni tutti gli aromi varietali che sono concentrati sulla buccia e danno un vino eccezionale”.