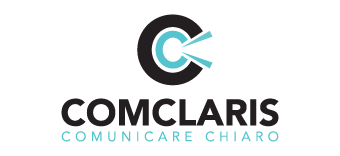Il santo precetto degli appassionati di ostriche è che il mollusco vada mangiato unicamente nei mesi con la erre. Dunque da settembre ad aprile, compreso gennaio, perché quando si parla di ostriche il pensiero corre alla Francia, Paese che vanta una lunga tradizione nell’ostricoltura. E lì gennaio fa janvier…
Se c’è un periodo nel quale procurarsi delle ostriche anche al supermercato è facilissimo, questo è quello delle festività di fine anno, durante il quale anche i diffidenti si lasciano tentare, complice il concetto che lega il consumo di questo cibo all’immaginario erotico e alla tradizione gastronomica.
In verità, non è vero che nel corso dei mesi estivi non si possano consumare le ostriche, ma bisogna sapere che in quel periodo il mollusco si riproduce, approfittando di un mare più caldo, e diventa un po’ lattiginoso, il che a qualcuno a livello gustativo può procurare un po’ di fastidio. Nessun pericolo però per la salute, come per anni qualcuno ha cercato di far credere.
Questa storiella delle ostriche da consumarsi solo nei mesi con la erre nasce essenzialmente per due motivi: il primo legato alle condizioni igieniche e di trasporto del mollusco nel corso dell’Ottocento, che in estate non erano certo paragonabili a quelle che abbiamo oggi grazie alla possibilità di controllare la temperatura; il secondo che si rifà invece alla proibizione di raccogliere le ostriche durante il periodo della riproduzione, decisa da Re Luigi XIII nel XVII secolo, per proteggere le coltivazioni dall’impoverimento dei banchi a cui erano sottoposte a causa del largo consumo.

La Route de l’huître, intinerari per golosi e buongustai sulle coste della Bretagna.
Un po’ di storia
L’ostrica è comparsa milioni di anni fa e i primi ad allevarla furono i cinesi. Anche gli antichi greci sembra che ne fossero ghiotti, per non parlare dei romani. Verso la fine del ‘600 sono segnalate piccole coltivazioni nei pressi de La Rochelle in Francia, dove si allevava soltanto una specie, l’ostrica piatta (Ostrea edulis), ma eravamo assai lontani da un’idea di ostricoltura dai grandi numeri, che comincia solo dopo la metà dell’Ottocento, quando la riproduzione naturale delle ostriche era messa a repentaglio dal vasto consumo e sul bacino di Arcachon per le coltivazioni si cominciò ad importare ostriche dal Portogallo (Crassostrea angulata) dette ostriche concave (o huitres creuses).
L’ostrica portoghese era scarsamente considerata dai francesi e si diffuse alla grande per due motivi: dapprima perché un carico che stava andando a male venne scaricato in mare dal comandante di una nave che non riusciva ad attraccare per le cattive condizioni meteo. Le ostriche che sopravvissero trovarono buone condizioni sulle coste francese e proliferarono. Fu una fortuna per i coltivatori di Francia che amavano soprattutto l’ostrica piatta (detta anche Belon), la quale venne decimata da una malattia nel 1920/21. La portoghese prese allora il sopravvento, ma fu a sua volta vittima di un’epidemia negli anni ’70 del secolo scorso e la sua presenza venne integrata con quella di un’ulteriore varietà importata dal Giappone.
Per farla breve, oggi in Europa abbiamo a che fare con due tipi di ostriche, la piatta e la concava, e la Francia è il Paese maggiormente implicato nella loro produzione e commercializzazione, grazie a bacini di allevamento che si situano in sette zone: la Normandia, la Bretagna del Sud e quella del Nord, la Loira, le Marennes-Oleron, il bacino di Arcachon (nei pressi di Bordeaux) e quello del Mediterraneo situato nell’Etang de Thau poco lontano da Montpellier. I dati europei dicono che la produzione è al 70% francese, il 20% irlandese e il 10% italiana, proveniente grosso modo da due zone, quella sarda di San Teodoro e quella veneta situata sul Delta del Po, che produce una qualità eccellente denominata ostrica rosa per le particolari striature della conchiglia.

Ostriche appena raccolte e portate nei bacini di affinamento.
Per farle crescere ci vogliono anni
Premesso che parlare di ostriche è un po’ come parlare di vini, con denominazioni di origine, “cru” particolari, label assegnati dalle differenti zone di produzione, insomma, roba da intenditori, è importante sapere che prima di arrivare in tavola uno di questi molluschi deve crescere nell’acqua per anni. Tra i mesi di giugno e agosto le ostriche madri lasciano le piccole larve in balia della corrente e queste nel giro di due settimane si fissano su corpi duri presenti nel mare. Gli ostricoltori le catturano con degli speciali collettori (tegole, tubi di cemento, ardesie, conchiglie infilate su delle corde), sui quali una volta appiccicata la larva sviluppa la conchiglia. All’incirca dopo 8 mesi le piccole ostriche hanno raggiunto la dimensione di 4 cm e hanno bisogno di più spazio per svilupparsi. Dopo essere state separate una per una, perché altrimenti non potrebbero svilupparsi, le baby-ostriche vengono portate nei parchi marini, dove ingrassano e in tre o quattro anni, sempre dopo diradamento, sono pronte per essere commercializzate e consumate. Alcune però vengono ulteriormente affinate in bacini ricchi di plancton e in acque meno salate: sono definite “claire” o “fines de claire” e crescono meglio quando sfruttano le acque dolci di qualche estuario, come avviene nel distretto francese di Marennes-Oléron dove passa il fiume Seudre. Da qui arrivano quelle che gli intenditori definiscono le migliori ostriche al mondo.
La misura dell’ostrica, che concorre a determinare il suo prezzo, si fissa in calibri. Per le ostriche concave si va da 5 a 0, dove il cinque sta per un’ostrica che pesa tra 30 e 45 grammi (la meno pregiata) e lo zero indica invece una misura di oltre 150 grammi. Analogo discorso per l’ostrica piatta, dove il calibro 0 indica però un peso tra 80 e 90 grammi e dunque si va oltre, fino al triplo zero, che significa un peso tra 100 e 140 grammi.
Freschezza assoluta
È il presupposto necessario per poter mangiare le ostriche. E la freschezza assoluta si trova ad una sola condizione, ossia che l’ostrica sia viva al momento dell’apertura. Il consiglio è di comprare la confezione intera, che permette di verificare la data del confezionamento, invece delle ostriche singole che potrebbero essere state dimenticate dal pescivendolo.
Di regola, se le valve sono già aperte prima del consumo e nella conchiglia non c’è acqua è meglio buttarle per non incorrere in gravi problemi intestinali. Si capisce, dunque, che per vivere le ostriche necessitano assolutamente della presenza di un po’ d’acqua nella conchiglia e l’ostricoltore le allena a questo scopo, vuotando e riempiendo i bacini in concomitanza con le maree due volte al giorno. Quando non sono sott’acqua, le ostriche trattengono il liquido serrando le valve e in questo modo si preparano ad affrontare il viaggio che le porterà sulla tavola del consumatore. Quanto riescono a sopravvivere fuori dall’acqua? Da un minimo di dieci giorni a due settimane.

In questi contenitori lasciati a lungo in balia delle onde l’ostrica cresce fino a raggiungere le dimensioni adatte alla sua commercializzazione.
Mangiamole crude!
E come si mangiano allora questi prelibati molluschi che qualcuno ritiene afrodisiaci? Qui le opinioni divergono. Intanto c’è la categoria dei “crudisti”, quella secondo i quali un’ostrica va sempre e solo mangiata cruda. E se il galateo dice che andrebbero mangiate con una forchetta apposita (c’è quella per le ostriche, piuttosto piatta e con rebbi larghi), la maggior parte degli estimatori considera che la miglior soluzione sia quella di «succhiare» l’ostrica direttamente dal guscio, senza far troppo rumore. Poi ci sono i puristi, che considerano blasfemo qualsiasi condimento: si mangiano al naturale, punto e basta, senza masticarle. La maggior parte di noi però aggiungerà due gocce di limone e una spruzzata di pepe. Personalmente dico no al limone, che ne altera il gusto di mare, e sì al pepe, ma con moderazione. Poi c’è il metodo francese, da non trascurare, dato che in Francia sono veri intenditori: si assaggiano con scalogno marinato in aceto, pepe e in accompagnamento a pane tostato con burro salato. Napoleone le adorava condite con un’emulsione a base di poco olio, sale, pepe, succo di limone e Cognac. Quante? In genere se ne servono sei a testa, ma dipende dalla nostra voglia e dal nostro amore per un mollusco che non solo è simbolo di raffinatezza e ci porta il mare in bocca, ma divide profondamente: o lo si ama alla follia, o lo si detesta.
L’ostrica cotta? Certo, si può e ci sono infinite ricette in proposito. Negli Stati Uniti va di moda cucinarla sulla griglia, ma secondo me è un delitto. Durante le festività natalizie ho voluto riprovare una ricetta con le ostriche gratinate: il risultato è stato eccellente, la pietanza arrivata in tavola mi ha soddisfatto, ma il sapore dell’ostrica? Svanito, evaporato. Allora tanto vale utilizzare dei molluschi di minor pregio: le pur buonissime coquilles st. Jacques o cappesante, addirittura le umili cozze, che gratinate sotto un po’ di pan grattato misto ad aglio, scorza di limone ed un trito di prezzemolo, poi condite con un buon olio d’oliva e sale e pepe, garantiscono una riuscita spettacolare a prezzi da saldi.

Le coquilles saintes-jacques o cappesante (ma anche capesante) sono ottime alternative all’ostrica gratinata e costano meno.
Non solo con le bollicine
E il vino? Anche qui pareri divisi. C’è chi dice che le bollicine uccidono i sapori dell’ostrica e sia preferibile un bianco fermo, meglio se Muscadet e meglio ancora se Sèvre et Maine, un bianco della Valle della Loira.
È di questo avviso anche Anna Valli, presidente della sezione Ticino dell’Associazione Svizzera dei Sommelier Professionisti (ASSP). “Il Muscadet Sèvre et Maine è un vino che sta parecchio sui lieviti e ciò gli conferisce un bel corpo e un bel volume. Ha una grande sapidità e un tenore alcolico piuttosto basso. Il tutto si sposa bene con le ostriche, che danno una bella succulenza con una tendenza al dolce e una salinità molto pronunciata. Non solo, ma l’ostrica ha una persistenza olfattiva e dunque necessita di un vino di carattere, molto avvolgente” dice la sommelière. Anna non è donna da classico abbinamento con lo Champagne.
“Secondo me è un abbinamento cliché, che richiama il lusso, l’esclusività, ma occorre saper andare oltre. Lo Champagne, con la sua componente molto acida, confrontato con la salinità dell’ostrica tende a creare una sensazione metallica che a me non piace”.
Personalmente sono un po’ tradizionalista: a me l’abbinamento ostriche-champagne non dispiace, ma ci vogliono degli champagne un po’ rotondi, con tendenza al fruttato, non quelli con un’acidità troppo pronunciata, che darebbero fastidio.Se proprio vogliamo abbinare alle ostriche una bollicina, le alternative peraltro non mancano: un buon Franciacorta nella versione Saten, che è morbido e ha un finale dolce, ma anche un buon Pinot Nero dell’Oltrepo’, e perché no, qualche interessante proposta locale: anche in Ticino sappiamo produrre degli ottimi spumanti.

Anna Valli, presidente dell’Associazione Svizzera dei Sommelier Professionisti, sezione Ticino
“Se vogliamo essere sconvolgenti, proviamo ad abbinare un ottimo Moscato d’Asti con le ostriche” mi dice Anna Valli pensando di scandalizzarmi. Eh no: chi scrive, dopo essere stato ospite dei produttori del Moscato in Piemonte ed aver provato l’abbinamento, è un sostenitore dell’accoppiata Moscato-acciuga, che sembra strana, ma ci azzecca di brutto: chissà, magari il Moscato funziona davvero anche con l’ostrica, ma ammettiamolo, è necessaria una certa dose di coraggio…