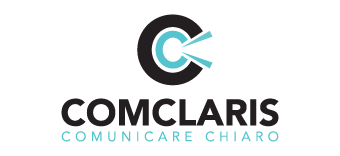Negli scorsi giorni, il 25 di gennaio, cadeva il centenario della prima Olimpiade invernale, che venne disputata a Chamonix dal 25 gennaio del 1924 al 5 febbraio dello stesso anno.
Se il grande circo olimpico (e nei primi anni della sua storia fu davvero un grande circo, con gare improbabili e persino divisioni razziali nelle competizioni) prende avvio con i Giochi di Atene nel 1896, prima di un’edizione invernale serviranno quasi trent’anni, durante i quali fu fatta opera di persuasione nei confronti dell’ideatore dei Giochi, il barone De Coubertin, fondamentalmente contrario ad un’edizione invernale della competizione, benché il pattinaggio avesse già fatto la sua apparizione durante i Giochi di Londra nel 1908 e l’hockey, sempre più popolare, comparve nel 1920 ad Anversa.
De Coubertin era contrario a delle edizioni olimpiche invernali soprattutto per ragioni che oggi definiremmo di «audience»: riteneva insomma che non ci fosse grande interesse per gli sport della neve, mentre gli scandinavi erano preoccupati dal fatto che le loro celebri competizioni nordiche potessero perdere popolarità a vantaggio dell’Olimpiade. Aggiungiamo il fatto che, contrariamente a quel che accade oggi, lo sci alpino era considerato un parente povero dello sci: allora era il fondo a primeggiare, mentre discesa e slalom, peraltro non ancora codificati (lo sarebbero stati solo nel 1929) erano considerati un passatempo snobistico per gente benestante ed esibizionista.

Prima della grande abbuffata olimpica e degli scempi a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, i giochi invernali non potevano che svolgersi nel cuore delle Alpi, dove alcune cittadine si distinguevano sia a livello di accoglienza, sia di infrastrutture, che all’epoca erano tutte naturali. Non fu dunque per caso che la seconda edizione dei Giochi (1928), divenuti ufficialmente «Olimpiadi», venne attribuita a San Moritz, che vinse una strenua concorrenza tutta rossocrociata per vederseli attribuire, battendo Davos ed Engelberg e guadagnandosi di fatto una fama immensa che ha saputo conservare e sviluppare negli anni.
A San Moritz per la prima volta anche il Ticino conosce l’Olimpiade bianca, grazie alla presenza del fondista airolese Carlo Gourlauen (foto), capostipite di una generazione di sportivi provenienti dal nostro cantone che ad anni di distanza da quella partecipazione ha saputo regalare trionfi incredibili alla storia dello sport ticinese.
La Confederazione finanziò i Giochi tramite un credito di 100 mila franchi concesso al Comitato Olimpico nazionale, 40 mila dei quali destinati agli organizzatori grigionesi, 60 mila alle spedizioni olimpiche rossocrociate, invernale ed estiva.
A San Moritz sono presenti 25 nazioni e 464 concorrenti e l’ambiente è festoso. I Giochi si aprono l’11 febbraio e terminano il 20 dello stesso mese. Annota il cronista de «Il Dovere», che per la prima volta dà ampio risalto alle Olimpiadi con servizi giornalieri: «San Moritz si fa bella, si veste da festa. Guai ora se il tempo si mettesse a fare il broncio: guai per tutti, per il comune, per gli albergatori e per i privati».
In realtà, quella degli organizzatori engadinesi finisce per essere una battaglia contro le condizioni meteorologiche: la neve, il vento e poi il favonio rischiano di rovinare i Giochi.
«Tutto è occupato, quasi più nessun letto. San Moritz è una babilonia di lingue, di divise, di distintivi, un reggimento di delegati ed un esercito di fotografi. Si vive in un ambiente anormale, ognuno s’improvvisa critico sportivo, ex-campione e cala lezioni a destra e a manca. I pronostici? Moltissimi e tutti disinteressati!» scrive il giornale bellinzonese, aggiungendo che sono presenti «ospiti di marca: il Principe Nicola di Romania, il principe-consorte d’Olanda. Ah sì, San Moritz dei ricchi e dei gaudenti!» .
Occorrerà fare un salto lunghissimo nel tempo per trovare la prima medaglia rossoblù ai Giochi invernali: Sarajevo 1984, il trionfo di Michela Figini, allora appena diciottenne, nella discesa. «Michi» ritroverà il podio olimpico quattro anni più tardi a Calgary ottenendo l’argento in super-G, quindi la decisione di ritirarsi che non le permise di gareggiare per la terza volta ad Alberville nel 1992. Aperta la strada, arrivano ancora le bellissime medaglie di Natascia Leonardi-Cortesi nel fondo (bronzo nel 2002 a Salt Lake City, staffetta 4 x 5 km), Nicole Bullo (bronzo con la nazionale femminile di hockey su ghiaccio a Sochi nel 2014) e la tripletta di Lara Gut, oro in super-G e bronzo in gigante a Pechino nel 2022 e bronzo in discesa a Sochi nel 2014.
Insomma, tutto si può dire dell’Olimpiade invernale, tranne che sia stata finora avara con i nostri sportivi.