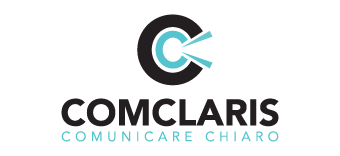In ricordo del collega Gianni Mura
22 marzo 2020
È una domenica che fa venire il magone, grigia com’è e da segregati in casa, e ci manca pure la sua rubrica, che da quasi quarant’anni la domenica ci teneva compagnia su Repubblica. Dove andranno ad abbeverarsi adesso i suoi fedelissimi?
C’è già molta nostalgia di te, Gianni Mura, che te ne sei andato senza far rumore lasciandoci orfani dei «Sette giorni di cattivi pensieri». Tu, che eri l’indiscusso condottiero del popolo dei Senzabrera, ci hai mollato in un momento così difficile dando vita di fatto alla generazione dei Senzamura.
Scommetterei che ti saresti divertito sapendo che avremmo coniato questo termine e da quel pozzo di scienza che eri, una vera enciclopedia delle parole, ci avresti fatto notare che alcune espressioni a volte possono assumere significati buffi: preso così, estraniato dal contesto, Senzamura ha una valenza positiva, esprime un concetto di libertà, quella libertà sulla quale hai impostato tutta la tua vita e la carriera giornalistica, sempre dimostrando profondo rispetto per gli altri.
Ammesso che, come ripeteva un mio vecchio caporedattore, il giornale del giorno dopo serva solo ad avvolgere l’insalata (e con questo voleva insegnare ai giovani a relativizzare, a non montarsi la testa per un articolo) non è da eretici affermare che il valore specifico dei testi pubblicati dai media dipenda da chi li firma e i «pezzi» certificati Mura avevano la capacità di sopravvivere alla fugacità del momento, di stamparsi dentro il nostro cuore, di diventare memoria viva, soprattutto per chi, ora già in età matura, esercita questo mestiere. Gianni Mura era una luce, il faro che illumina la notte, il porto sicuro. Il suo italiano era melodia e poesia, roba che quando uno che si definisce suo collega lo leggeva, poteva solo sentirsi piccolo e inadeguato, soprattutto sapendo che spesso i suoi articoli migliori erano dettati a braccio.
Gianni era un uomo apparentemente burbero, con la faccia scontrosa: nascondeva una timidezza che si scioglieva al primo approccio, meglio ancora se seduti a tavola a gustarsi qualche prelibatezza gastronomica e un buon bicchiere di vino. Lui amava i rossi, anche i nostri Merlot ticinesi, e siccome non conosceva troppo le mezze misure, detestava il rosé.
Ha raccontato il calcio e il ciclismo come nessuno e i suoi resoconti sulle tappe del Tour de France, probabilmente la manifestazione sportiva che amava di più, sono autentiche perle che escono dal contesto giornalistico per sconfinare nell’epica della narrazione.
Un po’ tutti lo consideravano l’erede di Giovanni Brera e lui sapeva di esserlo, pur avendo percorso strade diverse. Si era inventato uno stile tutto suo che gli permetteva di giocare delicatamente con le parole tirate fuori da un vocabolario senza limiti e da una cultura infinita, che spaziava dalla letteratura all’arte e alla musica e gli aveva permesso di avventurarsi anche nella narrativa, pubblicando alcuni romanzi che avevano ottenuto un buon successo.
Gli chiedevano sovente di immaginare cosa avrebbe scritto Brera dello sport attuale e Mura non si è mai sottratto all’esercizio: c’era una sorta di affinità elettiva tra i due e nell’interpretazione del pensiero breriano immagino che Mura esprimesse anche i suoi sentimenti, che non erano di sicuro entusiastici né per la dimensione assunta dal calcio e dal ciclismo (business, doping, perdita di identità), né per quella dell’attività giornalistica, troppo incline a spettacolarizzare il nulla a scapito del reale valore della notizia e in fuga dal suo habitat naturale, la carta.
Per Mura il vero giornalista era rimasto come l’oste di una volta, che portava in tavola antipasto, primo, secondo, formaggio e dessert, oltre ad un’abbondante porzione di vino. Oggi però viviamo nell’epoca del fast food dell’informazione, dove al cliente-lettore si serve di fretta «un’insalata di rucola e gamberetti perché il pane ingrassa, i salumi alzano il livello di colesterolo e il vino fa male».